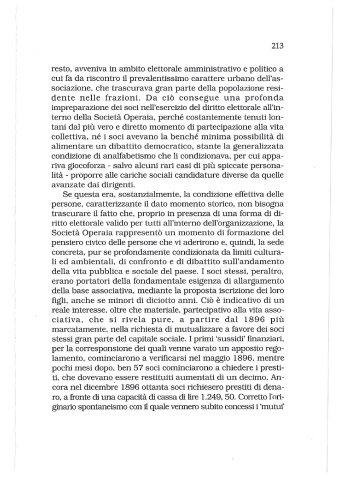Page 215 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
P. 215
213
resto, avveniva in ambito elettorale amministrativo e politico a
cui fa da riscontro il prevalentissimo carattere urbano dell'as-
sociazione, che trascurava gran parte della popolazione resi-
dente nelle frazioni. Da ciò consegue una profonda
impreparazione dei soci nell'esercizio del diritto elettorale all'in-
terno della Società Operaia, perché costantemente tenuti lon-
tani dal più vero e diretto momento di partecipazione alla vita
collettiva, né i soci avevano la benché minima possibilità di
alimentare un dibattito democratico, stante la generalizzata
condizione di analfabetismo che li condizionava, per cui appa-
riva giocoforza - salvo alcuni rari casi di più spiccate persona-
lità - proporre alle cariche sociali candidature diverse da quelle
avanzate dai dirigenti.
Se questa era, sostanzialmente, la condizione effettiva delle
persone, caratterizzante il dato momento storico, non bisogna
trascurare il fatto che, proprio in presenza di una forma di di-
ritto elettorale valido per tutti all'interno dell'organizzazione, la
Società Operaia rappresentò un momento di formazione del
pensiero civico delle persone che vi aderirono e, quindi, la sede
concreta, pur se profondamente condizionata da limiti cultura-
li ed ambientali, di confronto e di dibattito sull'andamento
della vita pubblica e sociale del paese. I soci stessi, peraltro,
erano portatori della fondamentale esigenza di allargamento
della base associativa, mediante la proposta iscrizione dei loro
figli, anche se minori di diciotto anni. Ciò è indicativo di un
reale interesse, oltre che materiale, partecipativo alla vita asso-
cia ti va, che si rivela pure, a partire dal 1896 più
marcatamente, nella richiesta di mutualizzare a favore dei soci
stessi gran parte del capitale sociale. I primi 'sussidi' fmanziari,
per la corresponsione dei quali venne varato un apposito rego-
lamento, cominciarono a verificarsi nel maggio 1896, mentre
pochi mesi dopo, ben 57 soci cominciarono a chiedere i presti-
ti, che dovevano essere restituiti aumentati di un decimo. An-
cora nel dicembre 1896 ottanta soci richiesero prestiti di dena-
ro, a fronte di una capacità di cassa di lire 1.249, 50. Corretto l'ori-
ginario spontaneismo con il quale vennero subito concessi i 'mutui'